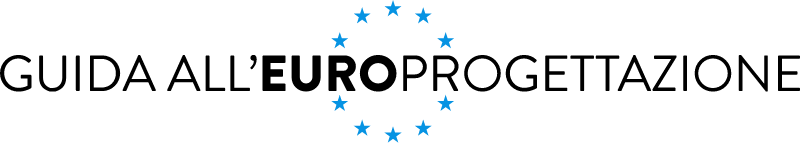FEAGA
Fondi Rurali – caratteristiche peculiari
Il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) fa parte, insieme al FEASR, dei fondi di applicazione della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione europea. Questi fondi, e in particolare il FEAGA, seguono logiche particolari, proprie di questo specifico ambito delle politiche comunitarie.
Lo scopo del FEAGA è fornire sovvenzioni e aiuti agli agricoltori e agli attori del mondo agricolo e rurale, attraverso un processo diverso da quello degli altri fondi e programmi comunitari. È un fondo gestito in modo indiretto dagli Stati membri (gestione concorrente).
Il FEAGA ha una filosofia di fondo e una modalità di gestione particolari. Forniamo in questa sezione, per completezza e coerenza con quanto fatto per i programmi europei, una trattazione delle caratteristiche principali del FEAGA.
Forniamo inoltre una più specifica trattazione dell’allocazione dei fondi FEAGA in Italia nella sezione dedicata ai Fondi Rurali.
Beneficiari potenziali
Agricoltori, aziende agricole, produttori e attori del mondo agricolo e rurale.
Descrizione e obiettivi
La Politica Agricola Comune (PAC) è una delle principali voci di spesa del bilancio dell’UE. Il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) è uno dei fondi europei finanziariamente più consistenti (ha un budget totale più elevato del FESR e di Orizzonte Europa). Come spiegato più sopra, ha una dinamica di funzionamento diversa dalla logica di altri programmi e fondi europei. Il FEAGA è un fondo di sostegno:
- Al reddito degli agricoltori, attraverso diversi regimi di pagamento, per garantirne la sostenibilità (Componente 1 – Sostegno al reddito);
- Al prezzo dei prodotti di origine agricola, per garantirne l’approvvigionamento e la stabilità (Componente 2 – Misure di mercato).
La PAC si compone nel suo insieme di queste due componenti, finanziate dal FEAGA; e da una terza componente (Componente 3 – Sviluppo rurale) finanziata dal FEASR. Le componenti 1 e 2, finanziate dal FEAGA, rappresentano circa i tre quarti del budget totale della PAC. La PAC, portata avanti fin dal 1962, è una delle politiche più “storiche” dell’Unione europea. Persegue i seguenti obiettivi:
- sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili;
- tutelare gli agricoltori dell’Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole;
- aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l’UE;
- mantenere in vita l’economia rurale promuovendo l’occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
I motivi alla base della PAC, del FEAGA e della loro rilevanza finanziaria per il budget comunitario sono molteplici:
- La produzione alimentare è fondamentale per la sussistenza e per l’indipendenza dell’Unione;
- Il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli;
- L’agricoltura è soggetta a incertezze climatiche e metereologiche e a una elevata competizione internazionale;
- Di conseguenza, gli approvvigionamenti agricoli sono soggetti a elevate oscillazioni di quantità e prezzo;
- La qualità del settore alimentare è fondamentale in termini di salute pubblica;
- L’attività degli agricoltori ha (nel bene, e potenzialmente nel male) un alto impatto sul mantenimento degli ambienti naturali, sul suolo, sulle risorse idriche e sulla biodiversità.
La PAC, e con essa il FEAGA, ha attraversato un importante processo di riforma. Nel biennio 2021-2022 è stato applicato un regolamento transitorio che ha esteso le regole già applicate nel precedente settennio 2014-2020. A partire dal 2023 è entrata in vigore una Nuova PAC (dettagli in coda a questo capitolo).
Tipologia di azioni e progetti
Il FEAGA è un fondo di sovvenzione gestito dagli Stati membri (gestione concorrente): le norme che ne disciplinano il funzionamento sono definite a livello europeo, ma ciascun paese provvede alla fase esecutiva. In particolare, le amministrazioni nazionali sono responsabili della gestione e del controllo del sostegno al reddito degli agricoltori nel loro paese. Come già ricordato, il FEAGA finanzia due componenti della PAC.
Nell’ambito della Componente 1 – Sostegno al reddito, il FEAGA fornisce ad agricoltori e aziende agricole un “pagamento diretto”, organizzato a sua volta in quattro canali principali:
- Pagamenti di base. Ogni anno gli agricoltori presentano una domanda di aiuto in cui dichiarano tutte le parcelle agricole dell’azienda. Il pagamento effettivo è versato agli agricoltori attivi in base all’attivazione dei diritti all’aiuto detenuti e calcolati in relazione agli ettari ammissibili da loro dichiarati;
- Pagamenti di inverdimento. Questa tipologia di pagamenti sostiene gli agricoltori che adottano o mantengono tre pratiche a beneficio dell’ambiente (in particolare del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità): diversificazione delle colture, mantenimento di prati permanenti e mantenimento di porzioni di terreno (aree di interesse ecologico) a colture che favoriscono la biodiversità (alberi, siepi o terreni lasciati a riposo);
- Pagamenti per giovani agricoltori. I giovani agricoltori ricevono un aiuto supplementare (per il quale gli Stati membri devono accantonare una riserva e definire criteri specifici);
- Regimi supplementari facoltativi. Esistono ulteriori regimi e criteri di pagamento specifici in supporto ai piccoli agricoltori (regime semplificato), alle piccole e medie aziende agricole (pagamento redistributivo), agli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali e ai settori che sono in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali (sostegno accoppiato facoltativo).
Nell’ambito della Componente 2 – Misure di mercato, il FEAGA finanzia misure volte a stabilizzare i mercati agricoli, a prevenire l’aggravarsi delle crisi, a stimolare la domanda e ad aiutare i settori agricoli dell’UE ad adattarsi meglio alle variazioni del mercato. Le misure di mercato sono a loro volta organizzate in tre canali principali:
- Intervento pubblico. Questa forma di intervento mira a evitare che i prezzi scendano a livelli eccessivamente bassi e viene attuata per alcuni settori particolarmente esposti alle fluttuazioni dei prezzi: frumento, grano duro, orzo e granturco, riso, carni bovine, burro e latte scremato in polvere. Si può applicare con un meccanismo di prezzi fissi (definito dall’UE per evitare che scenda al di sotto di un livello sostenibile) o mediante gare d’appalto (i prodotti vengono acquistati e immagazzinati dai governi o dalle agenzie dei paesi dell’UE a un prezzo prestabilito, per essere poi successivamente rivenduti in condizioni di mercato migliori);
- Ammasso dei prodotti da parte del settore privato. Quando i prezzi di mercato sono bassi, l’UE può fornire un aiuto agli operatori del settore privato per sostenere i costi di ammasso dei loro prodotti per un determinato periodo di tempo, per ridurre temporaneamente l’impatto di un eccesso di offerta. Si può applicare a zucchero bianco, olio di oliva, carne di manzo, burro, formaggio e latte scremato in polvere, carne suina, carni ovine e caprine e fibre di lino;
- Misure eccezionali, attuate per evitare e/o attenuare le conseguenze di un improvviso calo dei prezzi, dovuto a vari fattori (squilibrio nei mercati, perdita di fiducia dei consumatori dovuta all’esistenza di rischi per la salute pubblica, animale o vegetale, o altri problemi specifici);
- Regimi di aiuto per settori specifici (frutta e verdura, vino, olio di oliva, apicoltura, luppolo). Puntano a migliorare la capacità dei settori agricoli dell’UE di adattarsi alle condizioni di mercato e aumentare la loro competitività e sostenibilità;
- Questa componente include anche un programma per la promozione di un’alimentazione sana nelle scuole, per un maggior consumo di frutta e verdura fresche e di latte.
Principali novità
Come già ricordato, l’attuale regolamento ha attraversato una fase transitoria (2021-2022) e il lancio operativo di una “nuova PAC” a partire dal 2023. Le principali novità della “nuova PAC” sono:
- La focalizzazione su nove obiettivi-chiave: garantire un reddito agricolo sufficiente, aumentare la competitività, migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità, sostenere il ricambio generazionale, sviluppare aree rurali dinamiche, proteggere la qualità dell’alimentazione e la salute;
- Elaborazione di piani strategici nazionali della PAC, per integrare in una sola visione strategica (in linea con i suddetti nove obiettivi e le tipicità e i bisogni di ogni Paese) le misure di sostegno al reddito, le misure di mercato e lo sviluppo rurale. Questi piani permetteranno inoltre una maggior coerenza con il Green Deal europeo, la strategia europea per la biodiversità e la strategia “Farm to Fork”;
- Il perseguimento di un più coerente impegno “verde” nell’ambito della Politica Agricola Comune, attraverso condizionalità ambientali più stringenti per accedere al regime di sovvenzioni e maggiori incentivi e allocazioni per pratiche virtuose dal punto di vista ambientale e climatico;
- Una maggior attenzione al principio di equità nell’utilizzo delle risorse della PAC, attraverso una maggior attenzione alle piccole e medie aziende agricole, ai giovani agricoltori e alla parità di genere, alla corretta definizione di “agricoltori attivi”, alle condizionalità sociali e al rispetto degli standard occupazionali e alla convergenza dei livelli di supporto forniti nei diversi Stati e regioni d’Europa;
- Una maggior attenzione alla competitività del settore agricolo, attraverso regole per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e sul mercato, l’orientamento alla competitività di mercato del settore agricolo, allocazioni di riserva per fronteggiare eventuali crisi e misure specifiche per alcuni settori (es. vinicolo).