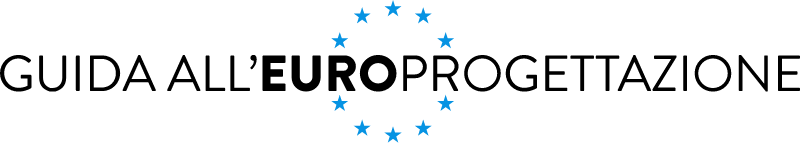I bandi top-down e bottom-up: conosciamoli meglio per poter scegliere il bando più adatto alla nostra idea progettuale
Dalla “lista della spesa” al progetto: approccio top-down e bottom-up nei bandi europei
Un progetto di successo comincia con la scelta del bando. Il punto di partenza è sicuramente quello di mantenersi aggiornati sulle opportunità di finanziamento, seguendo gli aggiornamenti sui siti web dei diversi programmi dell’Unione europea e su altri portali dedicati, come il nostro portale bandi, aggiornato mensilmente.
Ma sapere quali sono i bandi disponibili è solo il primo passo: quello successivo è capire, tra le tante opportunità, quali sono più in linea con la nostra idea progettuale. In questo articolo parleremo degli approcci top-down e bottom-up nei bandi europei, di come determinano il grado di flessibilità di un bando e delle strategie per sviluppare progetti in linea con ciascuno dei due approcci.
Paragonando un bando a una “lista della spesa”, è come se ci venisse richiesto di comprare “latte, pane e uova”, con la libertà di scegliere la marca del latte o il tipo specifico di pane o magari, perché no, di sostituire il pane con i cracker, purché si raggiunga l’obiettivo di “fare colazione”; oppure, se ci venisse richiesto di comprare un litro di latte di una marca specifica, due etti di pane di segale e sei uova biologiche. In un caso (indicazioni generali) ci troviamo in un approccio bottom-up, ovvero dal basso verso l’alto; nell’altro (lista più dettagliata) ci troviamo in una modalità top-down, ovvero dall’alto verso il basso.
Non c’è una modalità migliore dell’altra, perché ciascuna lista della spesa, proprio come gli approcci top-down e bottom-up, risponde a esigenze e metodi differenti: in un caso, nella lista dettagliata, si parte prima dalla visione di insieme, ad esempio dal menù della settimana, per poi definire a monte i singoli ingredienti, mentre nell’altro si considera principalmente l’obiettivo primario, quello di fare colazione, lasciando una maggiore scelta e la possibilità di sostituire un alimento con uno simile.
Se pensiamo a chi ha scritto la lista della spesa come all’ente finanziatore e a chi va effettivamente a fare la spesa come all’organizzazione/ente che presenta un progetto, potremo facilmente intuire quali possono essere alcune delle conseguenze, dei limiti e degli aspetti positivi del seguire un approccio rispetto all’altro.
Prima di approfondire ciascuno dei due approcci, è importante tenere conto che, nonostante si faccia spesso riferimento a top-down e bottom-up nelle politiche, nei programmi e nei bandi europei, non esiste una definizione ufficiale comunemente adottata. A seconda del programma e ambito di azione (ricerca, sviluppo locale, educazione, etc.), vengono infatti sottolineati aspetti e sfumature differenti.
Questo è il caso, ad esempio, della definizione dei due approcci nella guida Horizon Europe di APRE, dove le caratteristiche di top-down e bottom-up vengono declinate in base alle specificità del settore della ricerca e dell’innovazione. L’approccio bottom-up è detto anche “curiosity driven”, con riferimento soprattutto alla ricerca fondamentale e di frontiera.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali (FSE+ e FESR) l’approccio bottom-up è invece definito (più che in termini di innovatività), in termini di “sviluppo locale partecipativo”. Definito nel Regolamento (UE) 2021/1060 (Articoli 28 e 31-34), è un metodo di pianificazione, programmazione e attuazione in cui le priorità, gli obiettivi e le azioni da finanziare vengono identificati, proposti e definiti in modo sostanziale dagli attori locali e regionali (amministrazioni, partner economici e sociali, società civile).
Tenendo conto di questa importante premessa, andiamo quindi ad approfondire ciascuno dei due approcci, fornendo una definizione di partenza, identificando gli aspetti positivi e quelli più sfidanti, alcuni consigli ed esempi di bandi europei di riferimento.
L’approccio top-down
Come abbiamo visto, l’approccio top-down comincia con la visione generale, “il menù”, per poi procedere dall’alto verso il basso con un crescente livello di dettaglio. Questo significa che in un bando di questo tipo vengono identificati:
- gli obiettivi (generali e specifici) e il problema che i progetti presentati dovranno contribuire a risolvere;
- una lista di tematiche, topic, priorità, e di destinatari dell’intervento;
- una lista di risultati attesi (output e outcome) vincolanti, in alcuni casi con indicatori di performance e di impatto già delineati nel bando;
- una lista più o meno dettagliata di azioni finanziabili, a volte associate ad ulteriori vincoli (es. budget massimo per tipologia di attività).
Aspetti positivi e limiti dell’approccio top-down
L’approccio top-down è presente nella maggior parte dei bandi europei. Presenta infatti una serie di vantaggi:
- Favorisce la coerenza tra i progetti che vengono finanziati e le strategie dell’Unione europea. Le questioni e i problemi che il progetto deve contribuire a risolvere sono definiti chiaramente, garantendone l’allineamento;
- Permette un maggiore controllo rispetto ai risultati attesi, grazie alla presenza di indicatori di monitoraggio (KPIs) specifici. Anche per questo, è un approccio utile per gestire in modo efficace progetti complessi e di larga scala, in cui sono presenti molte azioni e attori differenti;
- Definisce in modo chiaro cosa ci si attende dai progetti e quali sono i requisiti, per cui le organizzazioni proponenti possono capire da subito quali sono esattamente le aspettative dell’ente finanziatore.
Questo approccio ha anche dei limiti:
- Una scarsa flessibilità, che può limitare il grado di innovazione delle proposte progettuali;
- Il rischio che si perda il contatto con la dimensione locale e con le sfide dei singoli territori;
- Il rischio che una determinata visione delle problematiche e delle soluzioni si riveli in parte o totalmente inaccurata, producendo scarsi risultati o esternalità negative.
Approcciarsi a un bando top-down
Approcciarsi a un bando top-down implica un’attenta analisi dell’aderenza dell’idea progettuale rispetto ai requisiti del bando. Occorre porsi le seguenti domande:
- Gli obiettivi della mia idea sono in linea o si discostano (e in che misura) dagli obiettivi del bando?
- L’area tematica della mia proposta rientra in quanto definito nel bando?
- Il mio progetto contribuisce in modo diretto e misurabile ai risultati attesi specificati nel bando? Sarà possibile per il mio progetto garantire questi risultati?
- La mia idea progettuale si adatta alla tipologia di azioni richieste?
Un progetto è particolarmente adatto per un bando top-down se:
- L’idea è stata concepita in modo autonomo dal bando, ma i suoi obiettivi, il settore e i risultati che persegue corrispondono con quanto richiesto dal bando. In questo caso, il lavoro di adattamento del progetto al bando non porterà a snaturare l’idea progettuale;
- L’idea è specifica e si declina nelle tipologie di azioni richieste dal bando;
- L’organizzazione proponente è in grado di costruire una proposta che rispetti tutti i requisiti e i vincoli, anche formali (come il numero di partner da coinvolgere, il livello di cofinanziamento etc.) richiesti dal bando.
L’approccio bottom-up
Nell’approccio bottom-up, invece, è molto chiaro qual è l’obiettivo generale del bando, mentre viene lasciato un maggiore spazio di manovra nel definire le modalità per raggiungere l’obiettivo. Questo significa che un bando di questo tipo:
- offre un quadro generale delle priorità strategiche e degli obiettivi generali, ma lascia una maggiore libertà e autonomia nel definire il problema che ci si propone di risolvere e gli obiettivi specifici del progetto;
- ha un ambito di intervento meno circoscritto: può prevedere macro-aree tematiche, ma senza indicare sottotematiche o topic specifici. In alcuni casi, non prevede alcun vincolo tematico. La tipologia di destinatari è definita in modo più ampio, con minori restrizioni;
- non prevede una lista di risultati attesi vincolanti, che spetta al proponente di delineare in modo credibile e misurabile, illustrandone l’impatto specifico e gli indicatori proposti;
- concede molta flessibilità nella definizione delle attività e delle risorse, limitata solo dalla coerenza con l’obiettivo proposto, con pochi vincoli in termini di budget e costi ammissibili.
Aspetti positivi e limiti dell’approccio bottom-up
L’approccio bottom-up è meno presente all’interno dei bandi europei, ma è utilizzato in alcuni ambiti, come quello dell’innovazione di base, della ricerca di frontiera e della partecipazione civica, in cui presenta alcuni vantaggi importanti:
- La possibilità di raccogliere idee e soluzioni trasformative e di sbloccare l’innovazione spontanea (aspetti non pianificabili “dall’alto”);
- La maggiore possibilità di adesione e pertinenza rispetto alle esigenze locali o di settori più specifici;
- La possibilità di valorizzare l’eccellenza, finanziando i progetti con il grado più elevato di creatività, indipendentemente da vincoli di temi o di approccio;
- Il maggior grado di inclusività, con la possibilità di finanziare organizzazioni, come le piccole e medie imprese, che spesso hanno più difficoltà ad accedere ai bandi di tipo top-down.
Anche nell’approccio bottom-up ci sono alcuni limiti e sfide:
- Il rischio di un più difficile allineamento strategico e di coerenza dei progetti rispetto alle politiche europee;
- La difficoltà di misurare l’impatto complessivo di un bando, che può essere più disperso in diverse iniziative e ambiti tematici, con indicatori per misurare l’impatto non uniformi;
- La maggiore complessità della valutazione delle idee progettuali, che possono essere molto diverse tra di loro;
- un maggiore sforzo richiesto per definire il problema, gli obiettivi specifici e gli indicatori di risultato, elementi che nei bandi top-down sono in gran parte già tracciati;
- Il rischio di una competizione molto elevata, proprio a causa della maggiore accessibilità di bandi che hanno focus tematici meno circoscritti.
Approcciarsi a un bando bottom-up
Approcciarsi a un bando bottom-up può sembrare più semplice solo inizialmente. La minore presenza di vincoli è infatti bilanciata dall’importanza data all’innovazione e soprattutto alla dimostrazione puntuale di come il progetto può realmente contribuire alla risoluzione del “problema” posto dal bando. Occorre porsi le seguenti domande:
- Qual è esattamente il problema che vogliamo affrontare?
- Perché finora nessun altro è riuscito a risolverlo?
- Qual è l’elemento di innovazione (o addirittura di rottura) della mia idea rispetto allo stato dell’arte attuale?
- Quali sono i rischi associati alla mia innovazione e come propongo di gestirli?
- I risultati attesi sono credibili, misurabili e raggiungibili con le risorse che ho pianificato?
Un progetto è particolarmente adatto per un bando bottom-up se:
- L’idea propone una soluzione altamente innovativa rispetto a un problema esistente, non ancora formalizzata o testata;
- L’idea identifica un problema specifico che rientra nella macro-area definita dal bando;
- Il progetto ha un alto potenziale trasformativo e di impatto, con la possibilità di una futura scalabilità e replicabilità
- L’organizzazione proponente è in grado di sviluppare un progetto che includa strategie per affrontare i rischi legati all’innovazione, ad esempio con attività flessibili e momenti di verifica intermedi.
Nell’approccio bottom-up viene spesso premiata l’interdisciplinarietà e l’intersettorialità, ovvero la capacità di un progetto di lavorare sinergicamente in più ambiti di intervento per la risoluzione di un problema comune.
Esempi di approccio top-down e bottom-up nei programmi europei
Non sempre è semplice individuare dei “casi tipici” di approccio top-down e bottom-up all’interno dei programmi europei: si tratta più spesso di una “scala di sfumature”. Ecco alcuni esempi.
Next Generation EU, declinato in Italia in un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede 7 missioni con aree tematiche specifiche, con la definizione di target, ovvero di risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili e da raggiungere entro un determinato periodo di tempo. A questi si aggiunge un sistema di indicatori comuni europei, che valgono per tutti gli stati membri e che vengono costantemente aggiornati. I bandi che ne risultano sono perlopiù molto specifici, e seguono un approccio top-down.
In contesti come Erasmus+ (la cui nuova guida per l’anno 2026 è stata recentemente pubblicata), troviamo un approccio ibrido: l’impianto generale è di tipo top-down, con obiettivi, priorità e aspetti trasversali (ne abbiamo parlato qui) chiaramente definiti. Alcune azioni, in particolare l’Azione chiave 1, includono però esempi di approcci di tipo bottom-up. È il caso dell’azione “Attività di partecipazione dei giovani” (KA154) che mette i giovani al centro del processo decisionale, con l’obiettivo di sostenere progetti che mirano a rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. In questo bando, i progetti stessi nascono dalle idee, dalle iniziative e dal dialogo dei giovani stessi. Gli animatori giovanili e le organizzazioni fungono da facilitatori, ma il motore del progetto sono i partecipanti. Proprio per questo, questa azione è aperta non solo alle organizzazioni, ma anche ai gruppi informali.
Un altro esempio di approccio ibrido è presente in Europa creativa, il programma di riferimento dell’Unione europea per il finanziamento di progetti nel settore artistico e culturale. Nei bandi per progetti di cooperazione europea (European cooperation projects), vengono definiti due grandi obiettivi relativi all’ideazione e creazione artistica, un obiettivo per la creazione e circolazione transnazionale e l’obiettivo innovazione, ma viene lasciata ampia libertà rispetto ai contenuti e alle tematiche affrontate dai progetti. Questi bandi sono inoltre organizzati in piccola, media e larga scala, con requisiti di partecipazione crescenti (numero di partner, numero di paesi europei coinvolti, dimensione del budget), per permettere la partecipazione, tramite la piccola scala, anche ad organizzazioni più piccole e meno strutturate (potete approfondire il tema della capacità organizzativa e dell’accesso ai fondi europei qui e qui).
È possibile trovare bandi orientati in modo molto deciso verso l’approccio bottom-up nei programmi di ricerca e innovazione, come Horizon Europe. Un caso emblematico è il EIC Pathfinder Open, un bando di Horizon Europe del Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC), l’organo principale dell’UE per l’identificazione, lo sviluppo e la scalabilità delle tecnologie e delle innovazioni. Il bando offre finanziamenti a team multidisciplinari per lavori di ricerca con il potenziale di sviluppare tecnologie dirompenti. Il Piano di Lavoro per il 2026 dell’EIC, con le informazioni relative a tutti i bando finanziati e le scadenze previste per il 2026, è stato pubblicato recentemente e presentato pubblicamente durante l’Infoday del 13 novembre 2025 (la registrazione dell’evento è disponibile qui ).
Abbiamo passato in rassegna sia l’approccio top-down che bottom-up, e visto come entrambi sono fondamentali all’interno dei bandi europei. Ciascuno presenta punti di forza e sfide che richiedono un’analisi attenta da parte di un’organizzazione interessata a candidare un progetto europeo.La chiave del successo è però la stessa per entrambi: valutare che ci sia un vero allineamento tra la nostra idea e l’obiettivo dell’ente finanziatore. È questa l’unica vera garanzia per evitare di tornare a casa… a mani vuote.