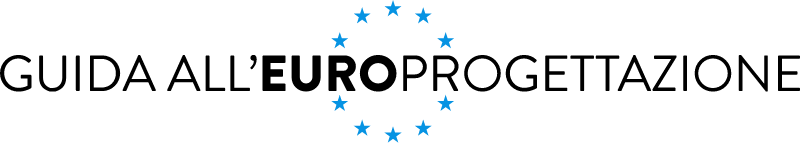Un approfondimento sui cosiddetti “aspetti trasversali” nella progettazione europea: esempi e consigli su come integrarli nei propri progetti
Gli aspetti trasversali nei progetti europei: che cosa sono?
Se pensiamo alla progettazione europea come a uno spettacolo teatrale, possiamo immaginare i progetti come gli attori, il programma (o il bando) come il copione e gli aspetti trasversali come la scenografia. Gli aspetti trasversali sono infatti la “cornice” della progettazione ma, come nel caso di una scenografia teatrale, sono molto di più di un elemento di contorno: si tratta di un insieme di temi fondamentali legati alle priorità politiche dell’UE che interagiscono con tutti gli aspetti del progetto, e che mirano a garantire che ogni azione finanziata con fondi europei contribuisca a valori e sfide comuni.
Gli aspetti trasversali sono quindi il contorno, o la “scenografia” di ogni progetto, ma ne costituiscono anche un aspetto sostanziale. Dovrebbero essere integrati in ogni fase, dalla progettazione fino alla valutazione del progetto. Si differenziano dagli obiettivi, che riguardano il settore specifico di intervento e che (riprendendo la metafora) rappresentano la “trama” del nostro progetto.
Non sono solo “dichiarazioni di intenti”, ma rispondono a requisiti specifici che troviamo nei programmi e nei bandi europei.
I principali aspetti trasversali che troviamo nella progettazione europea sono:
- L’inclusione e la diversità. I progetti devono essere accessibili e promuovere la partecipazione di persone con minori opportunità, combattendo ogni forma di discriminazione, in termini di genere, censo, origine, orientamento e condizione fisica (solo per citarne alcuni);
- La sostenibilità ambientale e la transizione verde. I progetti devono essere in grado di integrare il più possibile pratiche e attività che contribuiscono alla riduzione dell’impatto sugli ecosistemi e sulle risorse naturali, alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico;
- La transizione digitale e l’innovazione. I progetti, a prescindere dal loro settore di intervento, devono essere un’occasione per sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie digitali, migliorare le competenze digitali dei partecipanti e promuovere l’innovazione digitale nei metodi e nei risultati;
- La partecipazione civica e democratica. I progetti devono promuovere la partecipazione alla vita democratica, una maggiore conoscenza e consapevolezza dei valori fondanti dell’UE e l’impegno dei cittadini dal punto di vista sociale e politico.
Gli aspetti trasversali nei programmi europei
Questi aspetti trasversali vengono concretamente recepiti in modo simile all’interno dei principali programmi europei. Analizziamone alcuni.
Il programma Erasmus+ fa riferimento alle quattro priorità trasversali già indicate: inclusione e diversità, ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, trasformazione digitale, partecipazione democratica.
Nella pagina ufficiale dedicata a queste priorità sono presentati alcuni interessanti esempi di progetti per ciascuna delle priorità nella forma di brevi video-interviste. La guida Unlock the power of priorities, pubblicata quest’anno, offre suggerimenti pratici su come integrare le priorità prima, durante e dopo il progetto, con indicazioni utili anche al di fuori di progetti Erasmus+. Anche la guida INAPP su inclusione e diversità nelle proposte di mobilità è un utile strumento di applicazione.
Nel Piano strategico di Horizon Europe 2025-2027 sono stati definiti tre orientamenti strategici fondamentali (KSO – Key Strategic Orientation):
- Transizione verde, con una quota trasversale del budget del 10% destinata alla biodiversità (aggiuntiva rispetto al budget già specificamente previsto per l’azione climatica);
- Transizione digitale, con 13 miliardi destinati tra il 2021-2027 a tecnologie-chiave in ambito digitale;
- Un’Europa più resiliente, competitiva, inclusiva e democratica, un orientamento che include la ricerca sulla sicurezza civile, su un modello economico equo e rispettoso dell’ambiente, sulla salute e il benessere e sulla partecipazione democratica.
I KSO sono pensati in particolare per il secondo pilastro del programma, “Sfide globali e competitività industriale europea”, e in sinergia con il pilastro orizzontale di Horizon Europe “Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca” (qui per una visione d’insieme della struttura e pilastri del programma).
Nell’ambito dei Fondi Strutturali dimensioni molto simili sono – più che aspetti trasversali – “al centro della scena”. Il “Regolamento sulle disposizioni comuni“, che stabilisce le norme unificate per la gestione dei Fondi Strutturali, definisce 5 obiettivi strategici o “policy objectives” per l’insieme della programmazione (Programmi Regionali, Programmi Nazionali, e Cooperazione Territoriale):
- un’Europa più competitiva e intelligente,
- un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio,
- un’Europa più connessa, u
- n’Europa più sociale e inclusiva e
- un’Europa più vicina ai cittadini.
Questi aspetti sono dunque al tempo stesso sia trasversali, sia centrali nell’orientare i finanziamenti. Vengono normalmente menzionati anche al livello dei singoli bandi, con ulteriori requisiti a seconda dell’ambito di azione specifico. Ognuna di queste dimensioni trasversali è inquadrata nell’ambito delle politiche europee, che (come spieghiamo nel nostro manuale) sono alla base dei programmi, dei bandi e dell’assegnazione dei progetti.
Forniamo a seguire una breve analisi di ciascuna delle principali dimensioni trasversali, con un riferimento alle principali politiche europee cui si riferiscono, e alcune indicazioni per integrarle al meglio nell’ambito dei propri progetti.
Inclusione e diversità
Questo aspetto riguarda l’uguaglianza sociale, il principio di solidarietà, l’inclusione delle persone con disabilità, l’uguaglianza di genere, il rispetto delle minoranze e della diversità in ogni sua manifestazione.
Il fulcro dell’inclusione è l’accettazione delle caratteristiche che rendono unica ogni persona, mentre la diversità descrive la varietà intrinseca di una società, che si manifesta nel riconoscimento delle distinzioni tra gli individui per fattori come età, sesso, etnia, credo religioso, disabilità, orientamento sessuale, livello di istruzione, nazionalità.
L’integrazione di questo principio nei progetti si basa sul concetto del Leave No One Behind, ovvero assicurarsi che nessuno venga lasciato indietro prima, durante e dopo il progetto, rimuovendo il più possibile gli ostacoli fisici, culturali, sociali, economici, geografici alla partecipazione.
I documenti politici e strategici dell’Unione europea alla base di questo principio sono:
- il Trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 2;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, che pone l’accento sui valori di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia;
- Il Pilastro europeo dei diritti sociali, che include 20 principi per un migliore e più equo accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro giuste, protezione sociale e inclusione.
A questi si aggiunge la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), approvata nel 1950 dai 46 paesi facenti parte del Consiglio d’Europa, inclusi i 27 stati membri dell’UE, per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa.
Per quanto riguarda l’inclusione delle persone con disabilità (tema di cui abbiamo parlato in un recente articolo), documento chiave è la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Importante anche tenere conto della Legge europea sull’accessibilità, in vigore da giugno 2025.
In aggiunta, è utile fare riferimento alle Priorità della Commissione europea per il 2024-2029, in particolare alla priorità “Sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale” oltre alle azioni relative alla lotta alle discriminazioni incluse nell’azione “Costruire un’Unione dell’uguaglianza”.
Per approfondimenti a livello legislativo, consigliamo di visitare il sito EUR-Lex, un punto di accesso ufficiale alla legislazione dell’ Unione europea. Nella sezione “sintesi della legislazione dell’UE” sono disponibili delle brevi rassegne con link a documenti di riferimento organizzati all’interno di 32 ambiti tematici. Per quanto riguarda l’ambito inclusione e diversità, consigliamo di consultare la sezione sui diritti umani, la sezione giustizia, libertà e sicurezza e la sezione occupazione e politica sociale.
Per aggiornamenti sulle azioni concrete portate avanti dalla Commissione europea, un’altra fonte di riferimento è il sito di DG EMPL, la direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, che include una sezione dedicata alle politiche e alle attività di cui la direzione è responsabile.
Ecco alcuni consigli per un progetto più inclusivo:
- cercate di garantire un’equa rappresentanza delle differenze nel team di progetto e tra i destinatari;
- informatevi attivamente sulle esigenze dei destinatari in base alle loro differenze, per prevedere il supporto più adeguato;
- considerate non solo gli ostacoli, ma anche il contributo che i destinatari, proprio grazie alla loro diversità, possono apportare al progetto.
Uguaglianza di genere
Questo principio è parte del più ampio principio di inclusione e diversità ma, dato il suo peso crescente nella progettazione europea, gli dedichiamo un approfondimento.
L’uguaglianza di genere coincide con la presenza di “pari diritti, responsabilità e opportunità per donne e uomini, ragazze e ragazzi”(EIGE). L’uguaglianza di genere coinvolge e impegna pienamente sia gli uomini che le donne, per assicurare parità di accesso in 6 ambiti chiave definiti dal gender equality index: il lavoro, il denaro, la conoscenza, il tempo, il potere, la salute.
Riguardo all’uguaglianza di genere, i riferimenti principali a livello dell’UE sono:
la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (art.23);
il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, articoli 8 e 157);
La strategia dell’UE “ Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”, che stabilisce cinque aree prioritarie di intervento.
Segnaliamo inoltre la tabella di marcia per rafforzare i diritti delle donne, sviluppata all’interno delle Priorità della Commissione europea 2024-2029, che include link a ulteriori documenti e fonti, come il report annuale sull’uguaglianza di genere in Europa (disponibile per il 2025).
All’interno dei bandi europei, questo aspetto si traduce in requisiti come la presentazione di un Gender Equality Plan (GEP), tra i requisiti obbligatori di Horizon Europe, e l’incentivazione del gender mainstreaming. Il GEP è un piano strategico e organizzato, con il fine di promuovere e garantire l’uguaglianza di genere all’interno dell’ambiente lavorativo di aziende ed enti pubblici. Per gender mainstreaming nei progetti, si intende invece la considerazione sistematica delle differenze tra donne e uomini in tutte le fasi del progetto.
L’obiettivo finale è quello di promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini e di combattere la discriminazione, assicurando che tutti beneficino in modo equo delle misure adottate e che le disuguaglianze non vengano perpetuate.
Tre consigli per un progetto più equo dal punto di vista del genere:
- cercate di garantire un equilibrio di genere nel team di progetto e ai diversi livelli decisionali;
- includete la prospettiva di genere nell’analisi del contesto e dei bisogni in fase di progettazione;
- includere dati disaggregati per genere e indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione del progetto.
Transizione digitale e innovazione
La transizione digitale è una strategia per sviluppare una trasformazione digitale a beneficio di tutti, con un approccio che pone l’individuo e i valori europei al centro. Nelle intenzioni dell’UE, la transizione digitale deve essere in grado di mettere la tecnologia al servizio delle persone, di portare a uno sviluppo dell’economia digitale equo e competitivo, di creare spazi digitali sicuri, accessibili e inclusivi, di supportare le azioni per una maggiore sostenibilità ambientale.
Le politiche europee e documenti ufficiali di riferimento sono:
- la Bussola per il digitale 2030 , che definisce obiettivi strategici per il decennio digitale;
- la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale che promuove una transizione digitale che mette al centro la persona e basata sui valori dell’UE (ne abbiamo parlato qui);
- a livello legislativo segnaliamo, per i suoi aspetti innovativi, il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), prima legge al mondo che stabilisce norme armonizzate sull’IA, basate su un approccio orientato al rischio (rischio inaccettabile, alto, limitato, minimo).
Nel sito di EUR-Lex è possibile accedere, tramite la sezione dedicata alla ricerca e all’innovazione, sottosezione “politica in materia di ricerca e innovazione”, a una serie di link a documenti di riferimento, tra cui il programma Europa digitale 2021-2027.
Dal punto di vista dell’azione politica, il digitale e l’innovazione sono una delle dimensioni maggiormente trasversali, ma per approfondimenti specifici gli organi maggiormente coinvolti sono DG Connect e l’agenzia esecutiva HADEA. Nel sito di DG Connect è disponibile una rassegna delle politiche nell’ambito della società digitale, delle tecnologie digitali avanzate (inclusa l’intelligenza artificiale), della cooperazione internazionale nel settore digitale, dell’economia digitale.
Tre consigli per un progetto che contribuisca alla transizione digitale:
- in fase di progettazione provate a includere l’aspetto digitale delle attività fin dall’inizio, piuttosto che integrare componenti digitali in un secondo momento per rispondere ai requisiti del bando;
- includete indicatori di monitoraggio che riguardano la componente digitale sia dal punto di vista delle attività che della gestione del progetto;
- integrate la misurazione digitale della sostenibilità cercando di quantificare la diminuzione dell’impatto ambientale di un progetto grazie all’adozione di soluzioni digitali (es. riduzione di energia/emissioni), dimostrando come la transizione digitale sia un catalizzatore della transizione verde.
Sostenibilità ambientale e transizione verde
La sostenibilità ambientale è il principio che garantisce l’equilibrio ecologico a lungo termine, soddisfacendo i bisogni attuali senza compromettere le generazioni future. Si concretizza in sei obiettivi fondamentali: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse, economia circolare, controllo dell’inquinamento, tutela della biodiversità. La transizione verde è invece la strategia politica dell’UE che definisce la roadmap per attuare questo cambiamento, un processo che implica una trasformazione profonda e diffusa a livello economico, politico, sociale e culturale.
Le politiche europee di riferimento includono:
- il Green Deal europeo e la relativa comunicazione della Commissione europea;
- Legge europea sul clima , che sancisce l’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, accompagnata dal pacchetto di atti legislativi “Pronti per il 55” (Fit for 55) per la sua attuazione;
- Regolamento sulla Tassonomia dell’UE, un documento più tecnico, ma che fornisce la definizione più operativa di ciò che costituisce un’attività economica ambientalmente sostenibile.
L’importanza di questo principio emerge anche dal nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (la nuova proposta di bilancio della Commissione europea di cui abbiamo parlato qui) che prevede una spesa di almeno il 35% delle risorse per avanzare negli obiettivi fissati nel Green Deal.
All’interno delle priorità della Commissione europea 2024-2029, la pagina dedicata alla priorità “Mantenere la qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura” contiene utili approfondimenti, oltre ad un cronoprogramma degli avanzamenti a livello di politiche, azioni legislative e iniziative. Inoltre, una sintesi della legislazione europea relativa ad ambiente e cambiamenti climatici è disponibile sul sito EUR-Lex, con link a documenti di riferimento.
A questi si aggiungono numerosi documenti strategici con focus più specifici come la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e il Regolamento sul ripristino della natura, oppure, in ambito agroalimentare, la strategia Farm to Fork (di cui abbiamo parlato recentemente in questo articolo dedicato al podcast “Food for europe”).
Degli aspetti legati al clima e alla sostenibilità ambientale si occupano in particolare la direzione generale per l’azione per il clima, DG CLIMA, per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico, con elementi condivisi con altri direttorati come DG AGRI, responsabile del settore agricolo, e DG ENER, responsabile del settore energetico. Nelle homepage dei siti delle direzioni è disponibile una selezione di link a politiche, iniziative ed approfondimenti tematici.
Numerosi sono i requisiti nei bandi legati alla sostenibilità ambientale, in alcuni casi molto condizionanti, come la condizionalità rafforzata , sistema di regole obbligatorie che prevede il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per gli agricoltori che ricevono fondi della Politica Agricola Comune (alla PAC e ai fondi rurali dedichiamo ampio spazio nella guida).
Tre consigli per un progetto europeo che contribuisca alla transizione verde e la sostenibilità ambientale:
- includi azioni, anche piccole, che aiutino a ridurre l’impronta ecologica del tuo progetto, ad esempio con l’utilizzo di mezzi di trasporto a minor impatto ambientale, la definizione di standard anti spreco, la riduzione della plastica, etc.;
- considera includi indicatori di monitoraggio specifici per misurare il livello di sostenibilità ambientale del progetto;
- sviluppa azioni in grado di promuovere comportamenti virtuosi anche da parte dei destinatari del progetto, ad esempio prevedendo un budget adeguato per gli spostamenti con una minor impronta di CO2.
Partecipazione civica e democratica
La parola chiave di questo aspetto trasversale è partecipazione, intesa come la possibilità per le persone di esprimersi e contribuire alle decisioni che hanno un impatto sulla propria vita. Questo principio riguarda la possibilità di prendere parte alla vita democratica a tutti i livelli, locale, nazionale ed europeo, tramite opportunità significative in cui i partecipanti possono esprimere il proprio punto di vista, contribuendo a sviluppare un maggior senso di appartenenza alla comunità europea. Come aspetto trasversale, riguarda anche la capacità di un progetto di promuovere il pensiero critico, l’educazione ai media, le competenze civiche e interculturali, la comprensione dei valori condivisi dell’UE. In questo quadro la partecipazione giovanile è un aspetto chiave, un tema di cui abbiamo parlato anche con il nostro partner tecnico Europiamo in questo articolo.
I principali riferimenti dal punto di vista legislativo e delle politiche europee includono:
- Il Trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli del titolo II – Disposizioni relative ai principi democratici (art.10, 11 e 12);
- La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, in particolare il titolo V dedicato alla cittadinanza stabilisce i diritti civili e politici essenziali per la partecipazione;
- La Raccomandazione (UE) 2023/2836 sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche;
- La Strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 dedicata al coinvolgimento dei giovani.
Questo tema è al centro dell’agenda strategica della Commissione europea, con una delle priorità per il 2024-2029 che si concentra sulla protezione della democrazia e dei valori europei. Nella pagina dedicata a questa priorità è possibile, oltre ad accedere ad una panoramica dei diversi ambiti in cui questa priorità si declina (dalla libertà di stampa, all’alfabetizzazione mediatica passando per misure come la condizionalità rafforzata), anche accedere ad utili approfondimenti come il report 2025 sullo Stato di diritto nell’Unione europea.
Infine, nel sito EUR-Lex, nella sezione Giustizia, libertà e sicurezza, è possibile accedere a una rassegna di link a documenti di riferimento, in particolare nella sottosezione “Cittadinanza dell’Unione”.
Tre consigli per un progetto europeo che contribuisca alla partecipazione civica e democratica:
- Prevedi la possibilità per i destinatari di progetto di contribuire direttamente alle attività, ad esempio tramite azioni di co-progettazione o di monitoraggio civico (ne abbiamo parlato qui);
- Nella comunicazione sul progetto, includi se possibile attività di restituzione alla cittadinanza, eventi pubblici di dibattito e materiale divulgativo accessibile;
- Assicurati che il progetto sia strutturato in modo da fornire le informazioni necessarie e uno spazio sicuro ai destinatari per poter condividere ed esprimere i propri punti di vista .
Gli aspetti trasversali: la vera chiave dell’impatto?
Abbiamo visto cosa sono gli aspetti trasversali, da “dove vengono” dal punto di vista dei valori e delle politiche europee, come è possibile integrarli nei progetti e come si traducono in priorità e requisiti specifici nei programmi europei.
Gli aspetti trasversali non sono meri requisiti burocratici, ma veri e propri catalizzatori di impatto: se opportunamente integrati, permettono non solo di aumentare le chances di finanziamento, ma di valorizzare il potenziale trasformativo del singolo progetto, rafforzando l’allineamento tra politiche, programmazione e progetti europei.
Torneremo a parlare, nei prossimi mesi, degli elementi di questa “scenografia”, con approfondimenti, strumenti ed esperienze sui singoli aspetti trasversali.