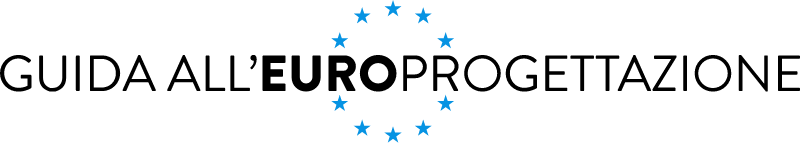La lingua della progettazione europea non è sempre facile : come evitare gli errori più comuni.
Le parole della progettazione europea
L’uso delle parole “giuste” nella progettazione europea è uno dei temi che più ci sta a cuore. Abbiamo dedicato un articolo a questo aspetto, proposto alcuni webinar dedicati e sviluppato un Glossario che contiene più di 200 parole chiave, che teniamo aggiornato.
Proprio come accade quando apprendiamo una lingua, anche nel mondo dei progetti europei esistono parole specifiche, termini ambigui, “falsi amici” e termini intraducibili da un contesto all’altro. Questo problema emerge anche quando presentiamo progetti all’interno di programmi europei differenti.
Ogni volta che ci avviciniamo a un progetto europeo, dobbiamo cercare di comprendere questi meccanismi linguistici e le modalità specifiche di utilizzo di un termine, per poter presentare un progetto che “parli la stessa lingua” dell’ente finanziatore. In questo articolo, analizzeremo alcune delle “trappole” più comuni, e forniremo alcuni consigli pratici per evitarle.
Progettazione europea, i “falsi amici” nell’utilizzo di termini: Italia vs progetti europei
Chi si avvicina per la prima volta alla scrittura di un progetto europeo può imbattersi nei cosiddetti “falsi amici”: parole che, pur essendo simili a termini che conosciamo, hanno in realtà significati diversi. Proviamo a fare due esempi tipici.
In italiano il termine “Consorzio” ha un’accezione molto specifica: è definito a livello giuridico (articolo 2602 del codice civile) e identifica una forma di cooperazione tra imprese per lo svolgimento di attività o fasi produttive.
Nell’ambito della progettazione europea il termine “Consorzio” ha un significato più ampio. La Guida Erasmus+ definisce il Consorzio come “Due o più organizzazioni partecipanti che si uniscono per preparare, attuare e dare seguito a un progetto”. Nulla a che vedere con un accordo tra sole imprese, ma qualcosa di molto più simile al termine più neutro di “partenariato”, come confermato dal nostro glossario: “Gruppo di beneficiari (call for proposals) o contractor (call for tenders). Corrisponde di fatto a un Partenariato”.
Il termine “Beneficiario” utilizzato in questa definizione è un altro “falso amico” che può generare confusione. Se nell’uso corrente questo termine indica colui che riceve un beneficio dalle attività di un progetto, nell’ambito dei progetti europei può indicare un membro del partenariato, che riceve fondi dall’Unione europea per svolgere le attività del progetto: quello che nell’uso corrente identificheremmo con il “partner”, non come il “beneficiario” di un progetto.
Le parole nei progetti europei possono ingannare, e avere più significati.
Parole diverse per indicare gli stessi concetti
Il caso inverso riguarda l’uso di parole diverse per indicare gli stessi concetti (o concetti molto simili) all’interno di programmi europei differenti.
Ad esempio, nei progetti europei, è molto comune l’utilizzo del termine “Work Package” (“pacchetto di lavoro” o “componente di progetto”): nel programma Erasmus+, Horizon Europe, Europa Creativa e molti altri, questo termine indica un blocco di attività tra loro simili, coerenti, interdipendenti o dedicate a uno stesso output specifico.
Questo termine è di uso corrente in molti programmi, ma non si applica al programma CERV: in questo contesto “Work Package” è sostituito dal termine “evento”, per via degli obiettivi di partecipazione, sensibilizzazione e coinvolgimento tipici del programma.
Un altro esempio riguarda i diversi termini con cui vengono definiti i contratti di convenzione che l’organizzazione capofila firma con la Commissione europea a nome del Consorzio. In programmi come Erasmus+, Europa Creativa e Horizon Europe parliamo di “Grant Agreement”, ma nell’ambito dei Fondi Strutturali la convenzione viene definita “Operation Agreement”. Pur con nomi diversi, entrambi i documenti formalizzano ruoli e responsabilità delle organizzazioni che ricevono il contributo nei confronti della Commissione e dell’Autorità di gestione.
Progettazione europea e neologismi
Esistono poi dei concetti, e dei termini, che nascono specificamente nell’ambito dei progetti europei. Ne sono un esempio i “regimi ecologici” (o “eco-schemes”): un neologismo coniato all’interno della PAC (la Politica Agricola Comune europea) che identifica misure volontarie che incentivano gli agricoltori a adottare pratiche più sostenibili per il clima, l’ambiente e il benessere animale, in cambio di pagamenti aggiuntivi. Sono specificamente progettati per incentivare l’assunzione di impegni ambientali mirati alle diverse tipologie produttive e ai territori.
Altro esempio è il termine “blended mobility” (mobilità mista), o Blended Intensive Programmes (BIP): un termine che non aveva un significato al di fuori di contesti molto specifici, ma che è diventato estremamente popolare all’interno del programma Erasmus+, tanto da diventare un termine-chiave del programma. Con questo termine si indica un format specifico, adottato in particolare in seguito alla pandemia, che combina un periodo di mobilità fisica all’estero con una componente virtuale (online), permettendo maggiore flessibilità e accessibilità.
Le parole intraducibili della progettazione europea
Nel lavoro sui progetti europei esistono diversi termini di derivazione anglosassone che sono stati direttamente adottati anche in italiano, in quanto non perfettamente traducibili.
È il caso della parola “Deliverable”, che in italiano non trova una traduzione univoca, ma viene resa con termini quali “prodotto”, “risultato”, o “documento di progetto”.
Il “Deliverable” (dall’inglese “deliver”, “consegnare”) ha un’accezione allo stesso tempo più ampia e più specifica rispetto alle sue possibili traduzioni, legata all’ambito specificamente progettuale. In questo ambito, il deliverable indica un risultato specifico e misurabile del progetto (per lo più – ma non solo – sotto forma di documento), che deve essere prodotto e presentato in un dato momento durante la durata del progetto.
Un’altra parola estremamente popolare nella progettazione europea è “Milestone”, che può essere solo in parte resa in italiano con il termine “traguardo intermedio”. Le “Milestones” sono punti o eventi significativi in un progetto che contrassegnano punti di controllo, risultati chiave o “abilitanti” per altri risultati o attività, o in vista della produzione e accettazione dei risultati finali (vedi glossario). Possono corrispondere al completamento di un “Deliverable” chiave e permettono il passaggio a una fase di lavoro successiva.
Tutto questo non è proprio facile da rendere in italiano con una sola parola. Il termine è stato infatti utilizzato tale e quale anche nell’ambito della gestione del PNRR.
Gli acronimi
Un altro aspetto cui prestare attenzione nella progettazione europea riguarda l’uso degli acronimi. Vi sono alcuni termini che hanno avuto maggiore diffusione nella forma di acronimo che nella versione estesa. In alcuni casi, l’uso comune prevede una variazione dell’acronimo a seconda della lingua (come nell’esempio banale di UE o EU), mentre in altri casi, spesso per una questione di leggibilità, viene utilizzata solo la versione in inglese. È il caso del programma Citizens, Equality, Rights and Values (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori), conosciuto come CERV anche in ambito italiano.
Un caso comune di utilizzo non corretto di un acronimo riguarda invece il programma Next Generation EU (NGEU), spesso “tradotto” in ambito italiano con PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In questo caso, l’acronimo italiano viene a volte impropriamente utilizzato per definire l’insieme del programma NGEU, mentre il PNRR riguarda esclusivamente il programma elaborato dall’Italia per gestire e utilizzare i fondi assegnati, in particolare quelli provenienti dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility). Quest’ultimo, sebbene comprenda circa il 90% dei fondi a disposizione del programma, rappresenta solo uno degli strumenti di NGEU, per cui l’utilizzo dell’acronimo PNRR per la totalità del programma (sia a livello europeo che a livello di strumenti di finanziamento) è improprio.
Le traduzioni automatiche
Infine ,nell’ambito della progettazione europea sono sempre più comuni le problematiche generate da un utilizzo poco attento delle traduzioni automatiche.
Sappiamo tutti, ad esempio, che modi di dire e frasi idiomatiche non possono (quasi mai) essere tradotte letteralmente, ma necessitano di un approfondimento per individuare la versione più aderente nella lingua di destinazione.
Per quanto riguarda singoli termini, in alcuni casi può essere più appropriato mantenere il termine nella lingua originaria.
Verbi inglesi come “mainstreaming”, ad esempio, nel contesto della progettazione europea, non si riferiscono tanto al rendere qualcosa “mainstream” (popolare, di massa), ma all’integrazione sistematica e trasversale di una specifica dimensione o prospettiva a livello di politiche, strategie, azioni e livelli di un progetto o programma. Per questa ragione, viene comunemente mantenuto il termine inglese (come ad esempio in “gender mainstreaming”).
Anche il termine “twinning”, tradotto letteralmente in italiano con “gemellaggio”, nell’ambito del programma Erasmus+ si riferisce comunemente all’iniziativa lanciata tramite la piattaforma eTwinning, (disponibile anche in versione italiana) che permette di sviluppare scambi e collaborazioni, principalmente online, tra docenti di differenti paesi dell’Unione Europea.
È inoltre interessante segnalare che esiste anche un sistema automatico di traduzione ufficiale, eTranslation, sviluppato nell’ambito del programma Europa Digitale dell’Unione europea.
I consigli per la progettazione europea
In conclusione, ecco qualche consiglio per diminuire la possibilità di malintesi:
- Mantieni la mente aperta: proprio come quando sei in viaggio in un paese straniero, apriti alla possibilità che le parole abbiano sfumature o significati molto diversi, senza dare nulla per scontato;
- Leggi molto: consulta le fonti ufficiali, i documenti programmatici, gli articoli settoriali e ogni altra fonte che possa aiutarti nel migliorare la tua padronanza della terminologia;
- Consulta i glossari: spesso i programmi europei pubblicano glossari specifici, da consultare soprattutto (ma non solo) nel momento in cui ci si appresta a presentare un progetto;
- Leggi il testo del bando europeo in lingua originale: se possibile, fai riferimento alla versione originale in inglese del bando, del regolamento e dei formulari, e solo in seguito, se necessario, consulta la versione italiana;
- Attenzione agli acronimi: consulta le fonti ufficiali per individuare la versione estesa corretta dell’acronimo; assicurati inoltre di utilizzare la versione in uso nella lingua in cui stai scrivendo il progetto;
- Attenzione alle traduzioni automatiche: affianca sempre la traduzione automatica a una revisione e controllo diretto in grado di assicurare l’esattezza e la qualità del contenuto; come specificato più sopra, leggere molto aiuta a comprendere le sfumature;
- Esempi di progetti finanziati: consulta e prendi esempio dai progetti già finanziati. Puoi trovarli ad esempio nella sezione “Projects & Results” del portale Funding & Tenders o in altri portali per programmi specifici, come la sezione “Projects” del portale ufficiale Erasmus+;
- Punti di contatto nazionali (NCP): se non riesci a trovare le informazioni necessarie per sciogliere un dubbio sul significato specifico di un termine, ricorda che esistono, per ciascun programma europeo, dei Contact point nazionali (ad esempio per CERV, LIFE, Europa Creativa per cultura e media, APRE per Horizon Europe, etc.) che possono fornire supporto;
- Partecipa a sessioni informative: durante l’anno vengono organizzate sessioni informative (molto spesso online), nella maggior parte dei casi dai Contact Point Nazionali, per fornire indicazioni e rispondere alle domande relative alla partecipazione a specifici bandi di finanziamento all’interno dei differenti programmi europei. Un’ottima occasione per sciogliere i dubbi e porre direttamente le proprie domande.
Alcuni glossari e fonti utili per la progettazione europea:
- Glossario di Horizon Europe (sviluppato all’interno del progetto Bridge2HE con l’obiettivo di migliorare l’accesso a Horizon Europe in cooperazione con tutti i National Contact Points del programma)
- Glossario della Guida 2025 di Erasmus+
- Glossario di Interreg
- Glossario di Interreg Central Europe
- Glossario di European Urban Initiative
- Numerose definizioni di termini chiave sono contenuti anche nell’Online Manual del portale Funding & Tenders